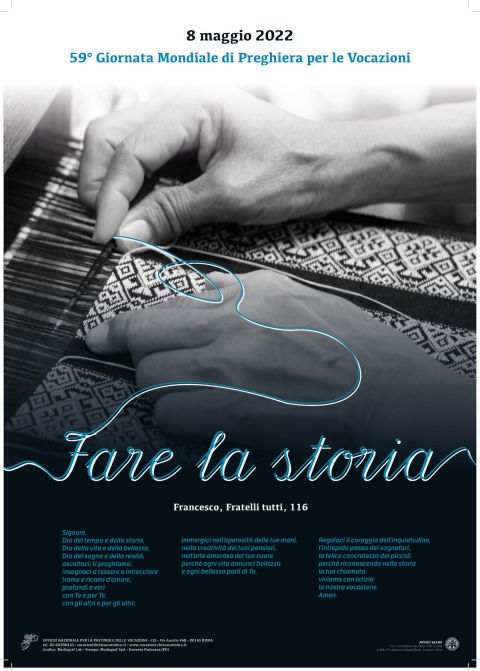L’8 maggio 2022, IV Domenica di Pasqua, si celebra la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni sul tema “Chiamati a edificare la famiglia umana”. Pubblichiamo di seguito il Messaggio che il Santo Padre Francesco invia per l’occasione ai Vescovi, ai sacerdoti, ai consacrati ed ai fedeli di tutto il mondo.
Cari fratelli e sorelle!
Mentre in questo nostro tempo soffiano ancora i venti gelidi della guerra e della sopraffazione e assistiamo spesso a fenomeni di polarizzazione, come Chiesa abbiamo avviato un processo sinodale: sentiamo l’urgenza di camminare insieme coltivando le dimensioni dell’ascolto, della partecipazione e della condivisione. Insieme a tutti gli uomini e le donne di buona volontà vogliamo contribuire a edificare la famiglia umana, a guarirne le ferite e a proiettarla verso un futuro migliore. In questa prospettiva, per la 59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, desidero riflettere con voi sull’ampio significato della “vocazione”, nel contesto di una Chiesa sinodale che si pone in ascolto di Dio e del mondo.
Chiamati a essere tutti protagonisti della missione
La sinodalità, il camminare insieme è una vocazione fondamentale per la Chiesa, e solo in questo orizzonte è possibile scoprire e valorizzare le diverse vocazioni, i carismi e i ministeri. Al tempo stesso, sappiamo che la Chiesa esiste per evangelizzare, uscendo da sé stessa e spargendo il seme del Vangelo nella storia. Pertanto, tale missione è possibile proprio mettendo in sinergia tutti gli ambiti pastorali e, prima ancora, coinvolgendo tutti i discepoli del Signore. Infatti, «in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo missionario (cfr Mt 28,19). Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 120). Bisogna guardarsi dalla mentalità che separa preti e laici, considerando protagonisti i primi ed esecutori i secondi, e portare avanti la missione cristiana come unico Popolo di Dio, laici e pastori insieme. Tutta la Chiesa è comunità evangelizzatrice.
Chiamati a essere custodi gli uni degli altri e del creato
La parola “vocazione” non va intesa in senso restrittivo, riferendola solo a coloro che seguono il Signore sulla via di una particolare consacrazione. Tutti siamo chiamati a partecipare della missione di Cristo di riunire l’umanità dispersa e di riconciliarla con Dio. Più in generale, ogni persona umana, prima ancora di vivere l’incontro con Cristo e abbracciare la fede cristiana, riceve con il dono della vita una chiamata fondamentale: ciascuno di noi è una creatura voluta e amata da Dio, per la quale Egli ha avuto un pensiero unico e speciale, e questa scintilla divina, che abita il cuore di ogni uomo e di ogni donna, siamo chiamati a svilupparla nel corso della nostra vita, contribuendo a far crescere un’umanità animata dall’amore e dall’accoglienza reciproca. Siamo chiamati a essere custodi gli uni degli altri, a costruire legami di concordia e di condivisione, a curare le ferite del creato perché non venga distrutta la sua bellezza. Insomma, a diventare un’unica famiglia nella meravigliosa casa comune del creato, nell’armonica varietà dei suoi elementi. In questo senso ampio, non solo i singoli, ma anche i popoli, le comunità e le aggregazioni di vario genere hanno una “vocazione”.
Chiamati ad accogliere lo sguardo di Dio
In questa grande vocazione comune, si inserisce la chiamata più particolare che Dio ci rivolge, raggiungendo la nostra esistenza con il suo Amore e orientandola alla sua meta ultima, a una pienezza che supera persino la soglia della morte. Così Dio ha voluto guardare e guarda alla nostra vita.
Si attribuiscono a Michelangelo Buonarroti queste parole: «Ogni blocco di pietra ha al suo interno una statua ed è compito dello scultore scoprirla». Se questo può essere lo sguardo dell’artista, molto più Dio ci guarda così: in quella ragazza di Nazaret ha visto la Madre di Dio; nel pescatore Simone figlio di Giona ha visto Pietro, la roccia sulla quale edificare la sua Chiesa; nel pubblicano Levi ha ravvisato l’apostolo ed evangelista Matteo; in Saulo, duro persecutore dei cristiani, ha visto Paolo, l’apostolo delle genti. Sempre il suo sguardo d’amore ci raggiunge, ci tocca, ci libera e ci trasforma facendoci diventare persone nuove.
Questa è la dinamica di ogni vocazione: siamo raggiunti dallo sguardo di Dio, che ci chiama. La vocazione, come d’altronde la santità, non è un’esperienza straordinaria riservata a pochi. Come esiste la “santità della porta accanto” (cfr Esort. ap. Gaudete et exsultate, 6-9), così anche la vocazione è per tutti, perché tutti sono guardati e chiamati da Dio.
Dice un proverbio dell’Estremo Oriente: «Un sapiente, guardando l’uovo, sa vedere l’aquila; guardando il seme intravvede un grande albero; guardando un peccatore sa intravvedere un santo». Così ci guarda Dio: in ciascuno di noi vede delle potenzialità, talvolta ignote a noi stessi, e durante tutta la nostra vita opera instancabilmente perché possiamo metterle a servizio del bene comune.
La vocazione nasce così, grazie all’arte del divino Scultore che, con le sue “mani” ci fa uscire da noi stessi, perché si stagli in noi quel capolavoro che siamo chiamati a essere. In particolare, la Parola di Dio, che ci libera dall’egocentrismo, è capace di purificarci, illuminarci e ricrearci. Mettiamoci allora in ascolto della Parola, per aprirci alla vocazione che Dio ci affida! E impariamo ad ascoltare anche i fratelli e le sorelle nella fede, perché nei loro consigli e nel loro esempio può nascondersi l’iniziativa di Dio, che ci indica strade sempre nuove da percorrere.
Chiamati a rispondere allo sguardo di Dio
Lo sguardo amorevole e creativo di Dio ci ha raggiunti in modo del tutto singolare in Gesù. Parlando del giovane ricco, l’evangelista Marco annota: «Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò» (10,21). Su ciascuno e ciascuna di noi si posa questo sguardo di Gesù pieno di amore. Fratelli e sorelle, lasciamoci toccare da questo sguardo e lasciamoci portare da Lui oltre noi stessi! E impariamo a guardarci anche l’un altro in modo che le persone con cui viviamo e che incontriamo – chiunque esse siano – possano sentirsi accolte e scoprire che c’è Qualcuno che le guarda con amore e le invita a sviluppare tutte le loro potenzialità.
La nostra vita cambia, quando accogliamo questo sguardo. Tutto diventa un dialogo vocazionale, tra noi e il Signore, ma anche tra noi e gli altri. Un dialogo che, vissuto in profondità, ci fa diventare sempre più quelli che siamo: nella vocazione al sacerdozio ordinato, per essere strumento della grazia e della misericordia di Cristo; nella vocazione alla vita consacrata, per essere lode di Dio e profezia di nuova umanità; nella vocazione al matrimonio, per essere dono reciproco e generatori ed educatori della vita. In generale, in ogni vocazione e ministero nella Chiesa, che ci chiama a guardare gli altri e il mondo con gli occhi di Dio, per servire il bene e diffondere l’amore, con le opere e con le parole.
Vorrei qui menzionare, al riguardo, l’esperienza del dott. José Gregorio Hernández Cisneros. Mentre lavorava come medico a Caracas in Venezuela, volle farsi terziario francescano. Più tardi, pensò di diventare monaco e sacerdote, ma la salute non glielo permise. Comprese allora che la sua chiamata era proprio la professione medica, nella quale egli si spese in particolare per i poveri. Allora, si dedicò senza riserve agli ammalati colpiti dall’epidemia di influenza detta “spagnola”, che allora dilagava nel mondo. Morì investito da un’automobile, mentre usciva da una farmacia dove aveva procurato medicine per una sua anziana paziente. Testimone esemplare di cosa vuol dire accogliere la chiamata del Signore e aderirvi in pienezza, è stato beatificato un anno fa.
Convocati per edificare un mondo fraterno
Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpellati ognuno personalmente da una vocazione, ma anche con-vocati. Siamo come le tessere di un mosaico, belle già se prese ad una ad una, ma che solo insieme compongono un’immagine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firmamento dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e rischiarino il cammino dell’umanità, a partire dall’ambiente in cui viviamo. Questo è il mistero della Chiesa: nella convivialità delle differenze, essa è segno e strumento di ciò a cui l’intera umanità è chiamata. Per questo la Chiesa deve diventare sempre più sinodale: capace di camminare unita nell’armonia delle diversità, in cui tutti hanno un loro apporto da dare e possono partecipare attivamente.
Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non solo di scegliere questa o quella forma di vita, di votare la propria esistenza a un determinato ministero o di seguire il fascino del carisma di una famiglia religiosa o di un movimento o di una comunità ecclesiale; si tratta di realizzare il sogno di Dio, il grande disegno della fraternità che Gesù aveva nel cuore quando ha pregato il Padre: «Che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre a un obiettivo comune: far risuonare tra gli uomini e le donne quell’armonia dei molti e differenti doni che solo lo Spirito Santo sa realizzare. Sacerdoti, consacrate e consacrati, fedeli laici camminiamo e lavoriamo insieme, per testimoniare che una grande famiglia umana unita nell’amore non è un’utopia, ma è il progetto per il quale Dio ci ha creati.
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il Popolo di Dio, in mezzo alle vicende drammatiche della storia, risponda sempre più a questa chiamata. Invochiamo la luce dello Spirito Santo, affinché ciascuno e ciascuna di noi possa trovare il proprio posto e dare il meglio di sé in questo grande disegno!
Roma, San Giovanni in Laterano, 8 maggio 2022, IV Domenica di Pasqua
Papa Francesco